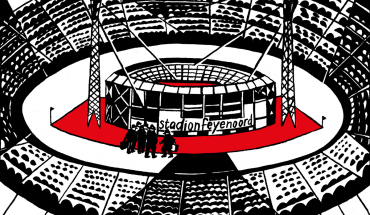Quello brasiliano è il mondiale dei portieri: Ochoa, Navas, Howard, Julio Cesar, Courtois, Neuer (libero aggiunto) e Enyeama. E ora che siamo nella fase calda, quella dove le partite hanno buone possibilità di andare oltre il 90°, non c’è cosa che esalti il goalkeeper più dei penalty. Inutile negarlo, ai portieri i rigori fan venire l’axillo (per chi non conosce il dialetto genovese: stato di eccitazione): finiscono i tempi supplementari, i tifosi sono in zona by-pass, ma c’è un giocatore che gode. Proprio così, gode: il portiere.
Per giocare tra i pali bisogna essere tante cose. Dicono che il portiere sia pazzo, che sia romantico, o più comunemente, che sia il ruolo della solitudine per eccellenza. Tutto vero, eh. Però io ho iniziato a giocare tra i pali perché nessuno ne “aveva per il belino”. Nel senso, quando si entra in una scuola-calcio tutti vogliono fare gol. In Italia, e a Genova in particolare, alla fine degli anni ’80 c’erano fior fiore di calciatori. Quindi è facile intuire perché nel 1988 nessuno volesse coprire il ruolo che fu di Garella. Io ci sono andato un po’ come quando si giocava in piazza: pensavo di essere il primo, di starci 5 minuti e poi uscire. Alla fine, invece, ci sono restato per tutta la mia breve carriera calcistica. Tutti volevano fare goal? Bene, io mi divertivo ad impedirglielo. E il massimo per me erano i rigori. Non avevo nulla da perdere: se prendevo goal era normale, ma se lo paravo ero l’eroe. Insomma mi trovavo nella condizione psicologica migliore: mi mettevo dietro la linea di porta, facevo un passo avanti fino alla riga, distraevo l’attaccante e provavo a prenderla. Spesso mi riusciva. E ho avuto anche il mio momento di gloria, raggiunto quando giocavo nelle giovanili del Genoa: parai 2 rigori su 5, perdemmo ugualmente e fu Aldo Spinelli in persona a consolarmi dalla sconfitta.
Non sceglievo a priori il lato da cui buttarmi, perché se il rigorista era bravo me la buttava dall’altra parte, mi spiazzavo da solo e tanti saluti. Certo, se il lato da me scelto coincideva con quello del mio avversario c’erano buone possibilità di prenderlo. Ma tutto restava troppo aleatorio. E non mi piaceva. D’altro canto non aspettavo neppure che il rigorista avesse calciato la palla: decidere di buttarsi a seconda della direzione del pallone significava partire in ritardo. E distanza e velocità, in questo caso, giocavano decisamente a mio sfavore. Lo si prendeva solo se era calciato molto male.
Quando paravo un rigore era questione di telepatia, quasi mesmerica (citando L’Armata dei Sonnambuli di Wu Ming), lo prendevo perché partivo contemporaneamente alla palla, sentivo che l’attaccante avrebbe tirato nella direzione da me scelta e guidavo il flusso del pallone dove volevo io. Facevo un passo fino alla riga di porta e un centesimo di secondo prima che la palla partisse mi buttavo. Ero in anticipo, sapevo che sarebbe andata da quel lato e avevo buone possibilità di acchiapparla. E godevo. Godevo nell’impedire l’accesso al goal, godevo nell’impedire all’attaccante di gioire e godevo nel sentirmi ultimo baluardo di difesa. E oggi, forse proprio per questo motivo, penso che il segreto per essere un buon portiere sia quello di essere anche un pò malvagi.
Sportivamente s’intende.
Ultimi post di Francesco Pedemonte (vedi tutti)
- Ernesto Colnago, l’uomo che ha rivoluzionato la bicicletta - 20 dicembre 2020
- Diego Maradona, il barrilete cosmico - 9 dicembre 2019
- Maradona è amico mio - 17 luglio 2018
- Duncan Edwards, il più grande - 17 maggio 2018
- Johann Trollmann, il pugile che sfidò il nazismo - 18 marzo 2018