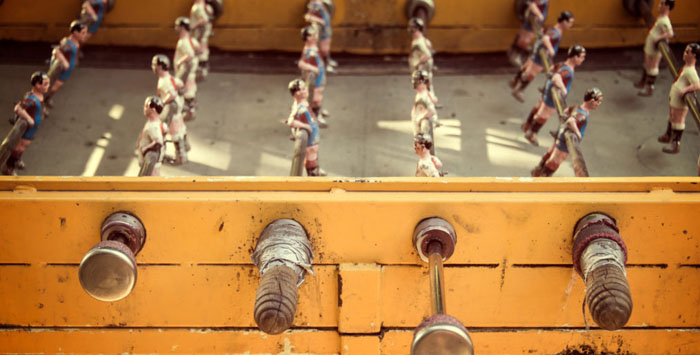“Chi, avendo un cuore per amare,
e in quel cuore coraggio,
avrebbe potuto trattenersi
dal rendere quell’amore manifesto?”
Macbeth – William Shakespeare
Quando alla mattina mi svegliai, avevo ancora in mente la sera precedente: mezzanotte, fuochi d’artificio, televisione, brindisi. E la bufera. Da sotto le coperte mi godevo il silenzio e, impaziente, cullavo l’attesa della giornata che stava per iniziare. Fuori dalla mia camera nessun motore; nella testa un unico pensiero: niente scuola, zero compiti e libertà; in casa, invece, un solo rumore: la cadenza regolare del russare di mio padre. Era il primo gennaio millenovecentonovantasette e Genova era sotto venti centimetri di neve. Il giorno prima avevo preso appuntamento con Alessio, Claudio, Simone, Augusto e Marco. Tre contro tre, pallone rosso e nessun limite di tempo. Il nostro campetto era l’ultimo nel quartiere di Dinegro. Una sopravvivenza effimera che, da lì a pochi anni, sarebbe evaporata a svantaggio di un parcheggio. Perfino i preti, lungimiranti nel diversificare la propria missione, avevano già preferito dismettere porte, spogliatoi e reti in favore di un più remunerativo silos. In via Digione, invece, resisteva l’ultimo dei campi in asfalto: due porte in metallo, niente reti, muri laterali in cemento, un buco a metà campo e le gradinate. Mancava tutto, eppure c’erano gli spalti. Tre file di gradoni, circa una ventina di metri e una scritta che ricordava un figlio del quartiere tragicamente scomparso proprio per una partita di pallone: Ciao Spagna, fratello amico e compagno. Su quel rettangolo grigio l’estate prima avevo vissuto il mio primo amore, dato un bacio ad una ragazza, fumato l’unica sigaretta della mia vita e giocato partite interminabili sotto il sole cocente. I match potevano durare anche cinque ore, perché guadagnarsi il diritto a fruire del campo era impresa titanica. I grandi, per ovvi motivi anagrafici, avevano sempre la precedenza. I più piccoli, invece, avevano forte rappresentanza per mezzo dei genitori. E noi, che eravamo la generazione intermedia, rivendicavamo il diritto a giocare tramite la ribellione o la prepotenza. A seconda dei rivali. Ma quella mattina, no. Avevamo programmato tutto. Come meteorologi avevamo deciso che la nevicata sarebbe durata tutta la notte; Claudio sarebbe passato a chiamare Alessio, assieme avrebbero citofonato a me e tutti e tre saremmo andati verso il nostro stadio. Con il resto della banda l’appuntamento era alle dieci. Le dieci del primo gennaio millenovecentonovantasette.
Quando arrivammo, tutto era bianco. La neve e il silenzio coprivano qualunque superficie. Scivolando sul culo, scendemmo la discesa che portava al campo. E non potevamo crederci: quello stesso tratto di strada su cui di solito facevamo le impennate, ora poteva essere addirittura sceso con lo slittino. Persino il ciccione del primo piano, che abitava di fronte alle porte e che ogni giorno d’estate svegliavamo dal riposino pomeridiano, se la rideva nel vederci cadere continuamente. Non indossavamo né tute da sci, né giacche a vento, né stivali. Il nostro abbigliamento d’ordinanza era il solito: jeans, bomber e scarpe da ginnastica. Che i piedi si bagnassero pure. Dovevamo giocare a pallone, che diamine!
La bufera dei giorni precedenti aveva sì creato le condizioni perché noi soli fossimo i padroni del campo, ma aveva anche offerto la stessa idea ad altri pretendenti. Inoltre, avevamo sottovalutato che era pur sempre il primo dell’anno. E quel giorno, come sempre dai tempi dell’invenzione della polvere da sparo, era dedicato alla raccolta dei petardi inesplosi nella notte precedente. A volte capitava di trovare qualche miccetta, di rado una fontana, quasi mai la fortuna di far brillare un magnum o un raudo. La neve, però, aveva drasticamente abbassato la possibilità di tale sollazzo e quindi restammo esterrefatti nel vedere il campo già occupato da tre figure. Ma un fischione ci rivelò subito la natura della loro presenza. Il problema dei razzi, in ogni tempo, è sempre stato quello di trovare una base di appoggio da cui farli decollare: a volte poteva essere una bottiglia, con un pò di ingegno i sostegni dello scivolo, altre ancora, ma era pratica per i più impavidi, due dita a distanza dal volto. Come ovvio, intuimmo subito che i venti centimetri di neve a terra rappresentassero una piattaforma ideale per il lancio, un punto di decollo strategico per un’intera batteria di petardi. Con il cuore gelato dalla delusione, tuttavia, entrammo nel campo da un buco della rete che lo delimitava. Ci avvicinammo ai dinamitardi e, senza avere il tempo di presentazioni o saluti, iniziarono a correre sciamannati verso di noi. Poco prima di scontrarci, però, riuscii ad intravedere un’architettura geniale, un sistema esplosivo sorprendente, almeno per me abituato ai minerva, e interamente finalizzato allo spettacolo pirotecnico: le micce di una dozzina di razzi, il cui stecco in legno era piantato nella neve, erano tutte collegate ad un unico cordoncino infiammabile che, a prima vista, mi sembrava troppo corto per far svolgere l’intera operazione in sicurezza. Comunque, la miccia ardeva e anche noi facemmo l’unica cosa sensata in quella situazione. Scappare. Quello che avvenne dopo fu magnifico: ad intervalli regolari, i fischioni decollarono tutti e il termine dello spettacolo, come da tradizione, venne sancito dalla deflagrazione finale di un botto. E anche dalle bestemmie del ciccione che minacciava di scendere e suonarcele. Quando la neve, infine, ricadde sul luogo dell’esplosione, mi accorsi che i pirotecnici erano tre ragazzi che conoscevo. E questo era un problema: come avremmo potuto giocare in 9?
Con Andrea, il più alto di tutti, avevo fatto catechismo per quasi 8 anni e non si contavano le volte che era riuscito a farsi mandare fuori dall’aula. Come da abitudine, anche quel giorno, portava un berretto con la visiera girata all’indietro, giacca di jeans e pantaloni strappati sulle ginocchia. Contro di lui feci a botte per la prima volta in vita mia, senza un vero motivo ma solo per la voglia di suonarcele e dimostrare agli amici che sapevamo incassare. La cosa non mi piacque: eravamo sempre stati amici e, oltre a fare a pugni, avevamo anche svolto una ricerca di storia assieme. In campo, invece, era uno che non si risparmiava. Ovviamente, quando ne aveva voglia. E grazie alle gambe da cigno riusciva ad arpionare palloni in qualsiasi situazione di gioco. Soprattutto quelli alti, visto che il gioco pericoloso era un fallo che nessuno aveva l’autorità di decretare.
Raul, invece, lo conoscevo meno. Era arrivato dal Cile qualche anno prima e subito si era imposto come randellatore di grande quantità. Aveva una corsa breve, quasi pigra e nessun senso del gioco. Per lui il campo era un’estensione della lotta che conduceva ogni giorno contro i professori. Il suo più grande successo, senza dubbio, fu il piano orchestrato per evitare la bocciatura. Una notte, contro ogni pronostico, riuscì ad intrufolarsi nelle aule, sottrarre dalla sala insegnanti il registro della classe che frequentava e uscire dall’edificio senza far suonare l’allarme. Aveva calcolato tutto, tranne le telecamere. E ovviamente a fine anno non venne promosso. Non gli interessava nulla della scuola, così come non gli importava giocare a pallone. A Raul piaceva provocare, sia in aula che in campo.
Il terzo bombarolo era Joel. Il nostro beniamino. Uno dei pochi che sapesse davvero dribblare, creare gioco e tirare. Aveva compiuto il suo apprendistato nei quartieri di Lima e la sua formazione calcistica, ai nostri occhi, appariva come un qualcosa di esotico, un ritmo sudamericano che rievocava i fasti di Maradona. Pareva fosse arrivato in Italia per fare un provino con una squadra di A, ma nessuno aveva poi saputo se fosse la verità. Quel che sapevamo era che quando Joel era in squadra si respirava finalmente profumo di riscatto e vittoria.
Poi c’eravamo noi sei. Io ero nato portiere, ma al campetto di stare tra i pali proprio non me la sentivo. Giocare in avanti è sempre stato il mio sogno, nonostante negare la gioia del gol abbia sempre appagato il mio ego più che adoperarmi per farne uno. Non ho mai avuto piedi fini, ma sapevo farmi apprezzare per incitamento, corsa e qualche apertura. Quando riuscivo a giocare senza la paura di sbagliare mi capitava di sentirmi quasi illuminato e, nonostante gli spazi angusti e l’asfalto irregolare, riuscivo ad anticipare la posizione del mio compagno e ad aprire l’azione verso l’ignoto. In quel momento sembrava che il dio del calcio avesse agito tramite me e che quel assist non potesse che andare bene. Peccato, ahimè, che il più delle volte calciassi addosso all’avversario e sull’azione successiva prendessimo gol per l’intransigenza della mia estasi. Con conseguente coro di insulti e imprecazioni.
Simone, invece, era un bomber. Ma a modo suo. In ogni squadra che facevamo si metteva di punta, di quelle che si piazzavano di fronte alla porta e non si sarebbero schiodate neppure con l’arrivo dei lampeggianti della madama. Aveva una corsa lenta, quasi da bradipo e soprattutto non c’era verso di fargli mettere piede nella propria metà campo. In compenso, però, là davanti i rimbalzi erano tutti suoi. Quando si era in squadra assieme, due cose erano certe: che si sarebbe dovuto correre il doppio e che avrebbe segnato solo lui. E questo creava sempre qualche malumore. Suo compare di scorribande e sovente anche di squadra, era Augusto, che litigava sempre con il proprio babbo. E che forse, proprio per questo, in campo si trasformava in toro. Lo chiamavamo locomotiva perchè non si fermava mai, correva sempre: a volte dietro il pallone, a volte senza meta. Sia che giocassimo venti minuti o due ore, lui terminava la partita in un bagno di sudore. Senza distinzione di stagione. Inverno o estate, non faceva alcuna differenza. Ogni ostacolo che incontrava, essendo alto quasi un metro e ottanta già a quindici anni, lo spazzava via. E avendo anche gli occhiali, sembrava davvero un locomotore impazzito. Poi c’era Claudio, il silenzioso. Parlava pochissimo e solo per comunicare l’indispensabile. Aveva un tiro potente e ogni sua azione era permeata di mistero. Spesso, ad esempio, scappava dalla partita e spariva per metà pomeriggio. Tra noi ci guardavamo straniti, sia per capire la sua meta sia per sostituirlo, e quando serafico tornava ai giardini raccontava beatamente di essere andato a comprare il latte. Un’estate, nel tentativo di imparare la tecnica delle tre dita brasiliane, passò interi pomeriggi a tirare contro il muro, raccogliere il rimbalzo e calciare d’esterno incrociando verso una porta immaginaria. Ovviamente i risultati non furono in linea con le aspettative: riuscì solo a sfondare le Superga che i genitori gli avevano comprato per la promozione e a centrare un vecchio che recitava il rosario salendo la strada. Che smoccolò uno ad uno i grani della propria preghiera.
La banda aveva anche il proprio re della supercazzola. Marco. In estate, quando baldanzosi approdavamo al campetto, lui era sempre lì. Seduto sul papero e sotto il sole. E dato che non eravamo mai in numero pari, cominciavamo da subito un estenuante e spesso infruttuosa opera di corteggiamento per convincerlo a giocare. Dalla sella del motorino non dava mai una risposta definitiva e ci condannava inesorabilmente all’ennesima olandese. Averlo in campo, d’altra parte, era un rischio. Quando miracolosamente cedeva alle nostre suppliche, infatti, si incaponiva in dribbling donchisciotteschi da cui usciva con espedienti al limite del regolamento. Appena intuiva che dal ginepraio di gambe in cui si era cacciato non sarebbe mai uscito palla al piede, si fermava, accarezzava il pallone e alzato lo sguardo diceva una cosa del tipo: «tarapìatapiòco, prematurata la supercazzola, o scherziamo?». Funzionava sempre, anche perchè la sua fantasia era multiforme e riusciva ad inventare una formula diversa ad ogni occasione. L’avversario si fermava, desisteva per un istante dalla contesa e, mentre chiedeva al novello conte Mascetti lumi sulle parole appena pronunciate, si trovava già irrimediabilmente dribblato. Marco poi arrivava sulla linea di porta e, a completamento della beffa, faceva gol con le natiche o di testa. L’affronto non veniva mai perdonato e la vittima, come giusto che fosse, iniziava a rincorrerlo senza sosta per il campo. Decretando l’automatica fine della partita.
A completare la rosa, infine, c’era Alessio, che citofonavamo sempre nella speranza scendesse in strada assieme a sua sorella, di cui tutti eravamo segretamente innamorati. Tale possibilità, puntualmente, non si realizzava e ogni volta rimettavamo al caso l’auspicio di poterla incontrare. Con buona pace dei nostri ormoni, che tenevamo in allenamento sulle pagine de Le Ore. Pur avendo un solo anno in più, lei frequentava la compagnia con cui duellavamo per l’uso del campo e le poche volte che si manifestava durante le partite, l’incontro si trasformava immediatamente in un’esibizione di calcio acrobatico. Anche se, paradossalmente, il più coreografico di tutti era suo fratello, che era fissato con i colpi di tacco e le rovesciate da metà campo. Giocare assieme era uno spasso, anche perchè al gesto d’impatto univa una favella straordinaria che attingeva dalle telecronache sportive, che registrava e studiava con proficua applicazione. Parlava continuamente, si sbracciava per chiamare palla con vocaboli che aveva coniato per l’occasione e, più che legittimamente, si inalberava quando non aveva la possibilità di seguire il copione che aveva redatto con cura certosina.
Al termine della conta, questa era la nostra banda. Una masnada di perdigiorno – come ci chiamava il ciccione del primo piano – che in quel giorno del millenovecentonovantasette si trovò riunita nello stesso campo innevato, spensierata come l’età che vivevamo e una voglia comune: giocare a pallone. Purtroppo, però, restava un problema, il più annoso di tutti: come fare in nove?
La soluzione era lì, a portata di mano. E venne in mente a Joel, il più creativo fra tutti noi. Giocando fisso a metà campo, in un’area di circa cinque metri di diametro, lui avrebbe fatto il jolly. Il nostro amico assicurava che avrebbe ricevuto palla, non avrebbe tirato o dribblato, ma soltanto passato il pallone al giocatore meglio piazzato della squadra che lo aveva chiamato in causa. La cosa era difficile, ma non c’era altra possibilità. Dovevamo fidarci. Con questi presupposti si aprì la più bella partita di non-calcio che la storia ricordi. A fischiare l’inizio fu il vento che, soffiando tra i palazzi affianco, non volle perdersi il primo grande evento dell’anno. In un turbine di fiocchi ed euforia, fu subito chiaro che Joel non avrebbe rispettato i patti. E non appena qualcuno gli passò il pallone, si mise a dribblare come un matto per tutto il perimetro in cui si era auto-confinato. Furono Raul e la neve a fermarlo, perchè noi, in una magica sinfonia di urla e imprecazioni, avevamo subito desistito. Come la neve che calpestavamo si sarebbe sciolta da lì a pochi giorni, allo stesso modo l’idea di mantenere due squadre evaporò in un soffio: ognuno giocava per sé, stipulava alleanze a seconda delle situazioni e trasformava in atto ogni idea folle suggerita dalla fantasia. Valeva tutto. E di tutto avvenne quel giorno. Marco, ad esempio, abbracciò senza alcuna remora quel carnevale anticipato e, come un castoro, costruì una palla di neve gigante in prossimità della porta che riteneva sua. Poco alla volta lo spazio per segnare si ridusse, procurando le inevitabili lamentele di Simone che, fedele al proverbiale immobilismo, era a caccia di rimbalzi per fare gol. L’aria di anarchia contagiò anche Claudio che, a folate, iniziò a fare scivolate per ostacolare l’inesorabile corsa palla al piede di Augusto. Io e Andrea, invece, a turno provavamo ad impossessarci del pallone e a dare un senso a quel tempo. Ma quel tempo un senso non lo aveva. E anche noi, alla fine, fummo risucchiati dalla potente orgia di divertimento che era calata sulla banda. Fu un caos meraviglioso, fatto di tuffi, tiri senza senso, parate acrobatiche, sculture di ghiaccio, palle di neve piccole e giganti, scivolate chilometriche, capriole, placcaggi, rovesciate e risate. Tante risate. Se il vento alzava la neve, saltavamo per abbracciarla; se fischiava verso il campo, ci lasciavamo cadere in terra; se di colpo si fermava, tornavamo ad inseguire il pallone. Tutto aveva un equilibrio. Incomprensibile per chiunque guardasse la scena dalle finestre di fronte, misterioso agli occhi di qualunque passante, ma rivelato e vissuto solo da noi che stavamo vivendo l’incanto in quel campetto. Solo Alessio sembrava fuori dal vortice, probabilmente perchè quello non era il copione che aveva immaginato. Eppure fu lui a trovare la parola che avrebbe fissato quel giorno nella memoria di tutti noi per sempre. In una delle rare azioni sensate della partita, mi ritrovai a saltare una scivolata congiunta di Claudio e Raul, un fungo atomico che avrebbe potuto fondere i malleoli di chiunque, e incespicando mi avviai zoppicante verso la palla gigante issata da Marco a difesa della porta. Affianco a me si palesò Alessio che, come sempre faceva in quelle occasioni, chiedeva gioco. Ma non lo fece con la formula che usava di solito, implorava che gli aprissi l’azione con una parola che aveva studiato apposta per quella tempesta. Nel silenzio che seguì alla prima pronuncia, tornò a ripeterlo: «Ouverture, Ouverture». Apertura, apertura.
Ovviamente non capii cosa stesse dicendo, mi portai il pallone sul destro, trattenni il respiro e tirai con tutta la forza che avevo. La palla scheggiò il muro di ghiaccio appena eretto, si impennò e andò a posarsi su un ramo carico di neve. Addio pallone e partita finita. L’incanto che per quasi due ore si era impadronito di noi svanì di colpo. Ognuno smise la maschera che aveva indossato e subito tornò ad essere se stesso. Solo Alessio, alterato come un puma, continuava a ripetere: «Ouverture, Ouverture». Apertura, apertura.
Sapevo di avergli dato un dolore, che forse avrei dovuto aprire, ma quello, lo avrei capito anni dopo, era il momento di chiudere.
E di giocare il primo atto.
di Francesco Pedemonte
Ultimi post di pagina2cento.it (vedi tutti)
- Gigi e Cassius Clay - 14 maggio 2018
- All’angolo - 14 maggio 2018
- Ordine 227 - 9 maggio 2018
- Lo specchio - 8 maggio 2018
- Palmira, bumaye - 7 maggio 2018